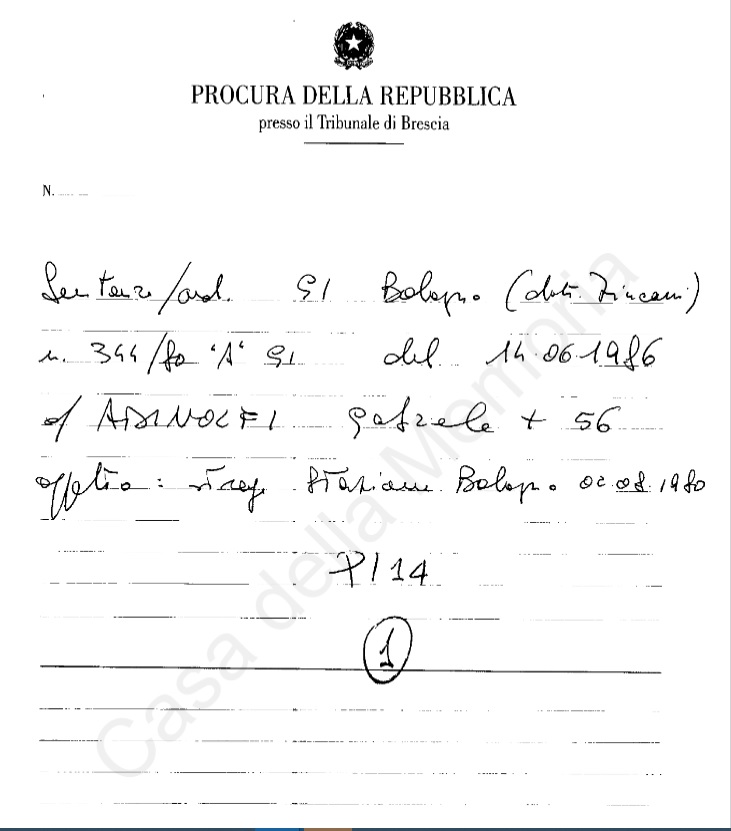Che cosa è successo nel 1969?
Scuola
07 Jun 2021
Il liceo statale "Niccolò Machiavelli" di Roma, in collaborazione con l'Associazione delle vittime della strage di piazza Fontana – 12 dicembre 1969, l'Archivio Flamigni, la Rete degli archivi per non dimenticare e Sapienza - Università di Roma - Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo ha realizzato il progettoChe cosa è successo nel 1969?, che si è concluso con la realizzazione di un video documentario,visibile su Youtube.

Iscriviti alla newsletter